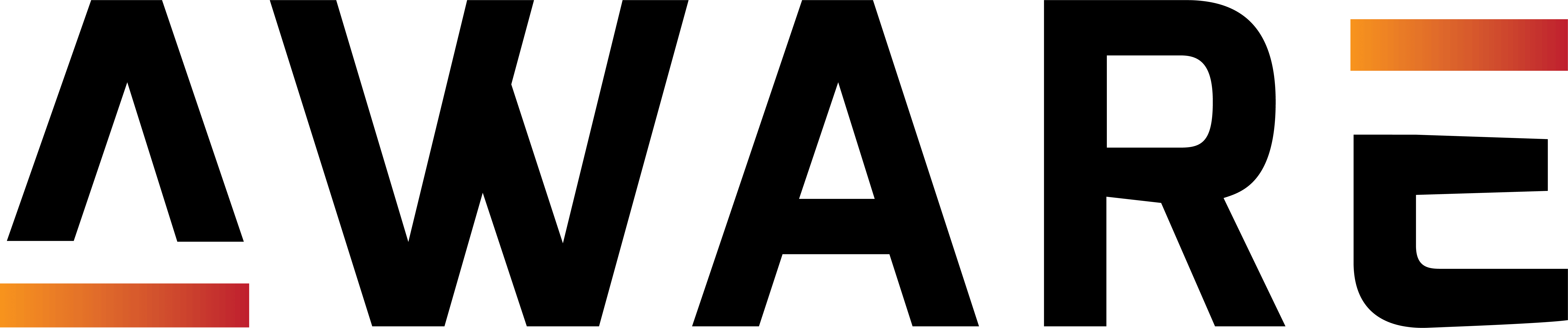Il legame tra alimentazione e sostenibilità socio-ambientale è sempre più evidente. Le nostre abitudini alimentari hanno infatti degli effetti, diretti o indiretti, sui diversi aspetti del contesto in cui viviamo: influiscono sul consumo energetico, sull’occupazione e la conformazione del suolo e, in molti casi, anche sulle condizioni di disuguaglianza sociale degli attori coinvolti lungo la catena del valore. Tuttavia, questi impatti non sempre sono facilmente percepibili o calcolabili. Il sistema alimentare, infatti, è complesso, e non riguarda solo l’uso intensivo del suolo, le pratiche monoculturali e l’utilizzo di prodotti di sintesi. Nell’equazione della sostenibilità dei nostri sistemi alimentari sono determinanti anche la dimensione sociale, economica, e culturale. Esiste un paradosso, ad esempio, per cui esistono più obesi che malnutriti al mondo, e che ci dice come il nostro modello alimentare non abbia esclusivamente conseguenze ecologiche, ma anche socio-sanitarie. Un altro esempio ci suggerisce che le nostre abitudini alimentari incidono sul bilancio statale: la riduzione di alcune patologie collegate alla nutrizione, come diabete o disturbi cardiovascolari, può avere riflessi finanziari positivi riducendo il peso sui sistemi sanitari nazionali. Cosa è necessario quindi per garantire un equilibrio tra la domanda di una popolazione mondiale nutrita in maniera sana e sufficiente, e l’offerta agroalimentare? Vale a dire, esiste un paradigma sociale, economico, culturale ed ambientale che si possa definire sostenibile?
Il report FAO 2021 Indigenous Peoples’ food system propone una risposta a questa domanda, presentando la storia di otto sistemi alimentari indigeni e il loro approccio basato sulla conoscenza, sull’esperienza e sulle pratiche locali. Nella pubblicazione sono descritti il popolo Baka del Camerun, gli Inari Sami finlandesi, i Meghalaya in India, i Malesiani nelle Isole Salomone, Kel Tamasheq in Mali, Tikuna, Cocama e Yagua in Colombia e Maya Ch’orti in Guatemala. I sistemi che li caratterizzano combinano diverse tecniche di produzione del cibo. Ne sono un esempio la raccolta, la caccia, la pesca, la pastorizia e la coltivazione itinerante. La natura mobile, incluso il nomadismo, è essenziale per collegare la generazione e la produzione di cibo ai cicli naturali in modo resiliente: consentono agli habitat di riprendersi e consentono agli ecosistemi di ricostituirsi.
Il popolo Baka, ad esempio, è ritratto come una civiltà avente una relazione ancestrale forte con la foresta, che è per loro terreno stagionale di raccolta, caccia, pesca e fonte medicinale. La sopravvivenza di questa civiltà dipende appunto dall’alternarsi ispezioni stagionali nella foresta e attività di produzione sedentaria nel villaggio. Diversamente, il popolo Khasi in Meghalaya, India, basa il suo equilibrio di sussistenza sulla tecnica della coltivazione itinerante insieme alla gestione di orti domestici, caccia e scambio di mercato. Nelle Isole Salomone, invece, alcuni melanesiani combinano l’agroforestazione, la raccolta di cibo selvatico e la pesca per generare il 70% della loro dieta. In generale, il cibo indigeno è un prodotto coltivato, cresciuto, preparato, preservato, condiviso e scambiato entro i limiti territoriali e stagionali, nel rispetto dei valori di interdipendenza, rispetto, reciprocità e sensibilità ecologica. L’equilibrio intimo che creano è però reso possibile anche da una forte identità culturale che mette la tradizione e la storia al centro dell’azione.
Ma è possibile applicare modelli come questi in una dimensione occidentale, progressista e globalizzata? Come possiamo far funzionare concetti dicotomici come tradizione e avanzamento? Un’opzione per avviare questo processo sta nel ripartire dai territori, avviare percorsi di cambiamento socio-ecologico, pensando alternative concrete al consumo di massa e all’agroindustria, facendo più forti i legami tra chi produce e lasciando posto ad una società liquida, definita così per la ricerca aperta verso un nuovo senso di comunità. Usando altri termini, dobbiamo impegnarci, come gli indigeni fanno, nella nostra capacità di fare sistema. Oggi in Italia gruppi di cittadini si organizzano in comunità per lo sviluppo locale, autodefinite cooperative. Le cooperative di comunità sono un modello di innovazione sociale, oltre che di reti agroalimentari alternative, dove i cittadini della comunità si organizzano per produrre e godere di beni e servizi all’interno della comunità, in una visione di sviluppo e coesione. Il modello nel nostro paese trova maggiore diffusione nelle aree interne, rurali, nella prospettiva di valorizzare la coesione sociale economica e territoriale. In Calabria, per esempio, ci sono diverse cooperative di comunità in piccoli borghi, come Arena o Fiume, che recuperano le tradizioni agricole, pastorali e artigianali per valorizzare le risorse, le competenze ed il territorio. La cooperativa di Arena è sorta su iniziativa di giovani agricoltori, imprenditori locali e agronomi che hanno scelto di investire sul recupero e sulla salvaguardia di un antico fagiolo autoctono, a zicca janca. La rinascita del fagiolo ha rappresentato metaforicamente la rinascita del paese, consentendo alla comunità di recuperare un’antica tradizione, di convertire i terreni abbandonati creando contestualmente occupazione e servizi. La comunità di Fiume invece si è impegnata nella gestione di un orto di comunità, nella produzione di cibo equo e giusto, nella vendita diretta di prodotti locali e nella creazione di spazi di socializzazione. La rilocalizzazione di pratiche di consumo e di produzione del cibo ha quindi costituito un attrattore per i giovani del posto che hanno trovato nella Cooperativa uno sbocco occupazionale, e che hanno costruito comunità intorno ai prodotti della terra.
Le aree interne, anche chiamate ‘spazi vuoti’, sono quindi i luoghi dove il ritorno alla terra crea economie di luogo resilienti, in grado di rispondere meglio alle necessità delle aree rurali frammentate, grazie alla capacità di interiorizzare i problemi sociali, occupazionali e i bisogni emergenti. Il carattere resiliente nasce dalla struttura dell’impresa collettiva, dalle finalità e dal modello di governance che pone il protagonismo sociale al centro, rafforzato e reso più autonomo da una assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, i quali vogliono essere parte attiva del cambiamento. A tal proposito, il Vertice delle Nazioni Unite del 2021 ha riunito agricoltori, pescatori, giovani, popoli indigeni, leader mondiali, capi di Stato e di governo per dialogare riguardo un modello agroalimentare giusto. Durante il Vertice si è proposto un incontro maggiore tra scienza occidentale e conoscenza bioculturale indigena, in un’ottica di inclusione socio-ecologica e di politiche agro-alimentari più vicine alle realtà locali che permettano l’integrazione delle dimensioni economica, ambientale, sociale e culturale. Il livello territoriale, che troviamo centrale sia negli indigeni che nelle cooperative, e che quindi possiamo considerare come caso sia globale che nazionale, è il livello individuato come indispensabile per applicare il principio di sussidiarietà e tradurre concetti generici in interventi e programmi concreti ed adatti. Affrontare questo tema richiede la collaborazione di diversi attori, ma anche la co-creazione di conoscenza da parte delle comunità di agricoltori,contadini e indigeni insieme agli istituti di ricerca, alle organizzazioni della società civile e ai governi. La sfida è dunque quella di utilizzare al meglio le relazioni tra attori in un accordo globale, nazionale e locale di inclusione, comunità e prosperità che metta al centro il patrimonio bioculturale di cui godiamo.