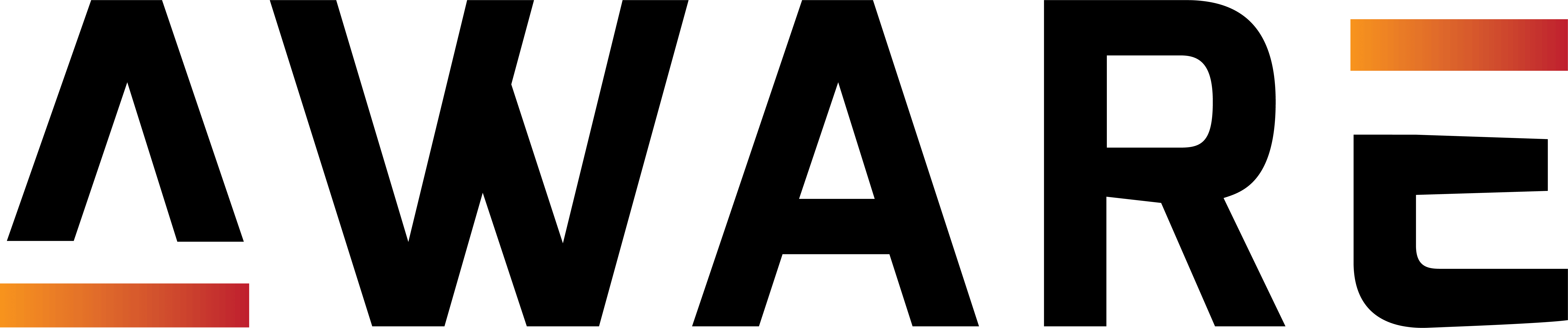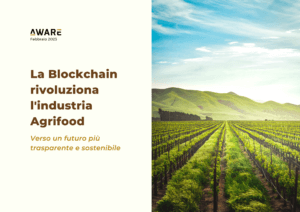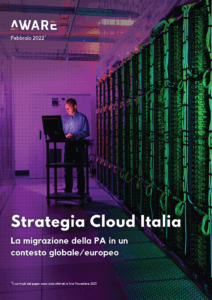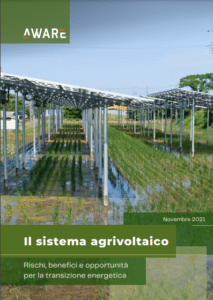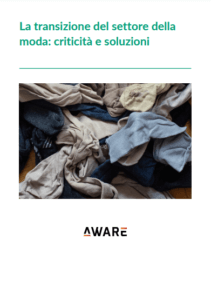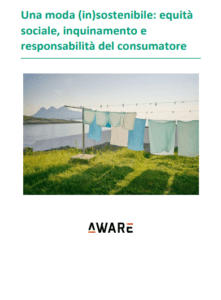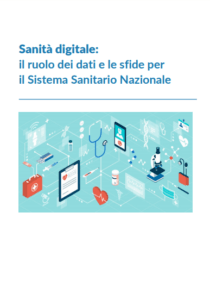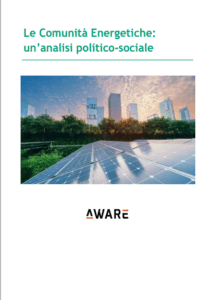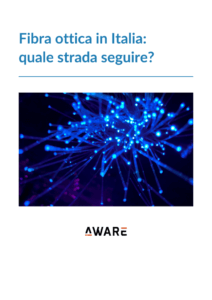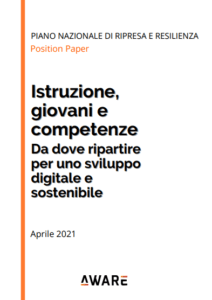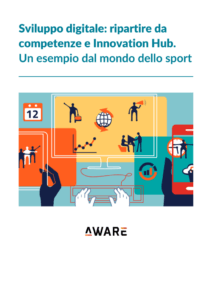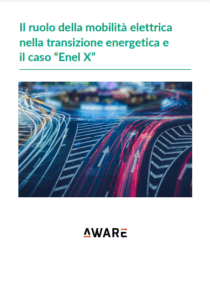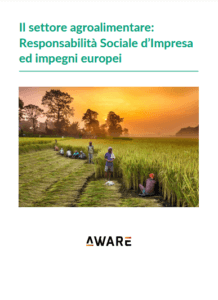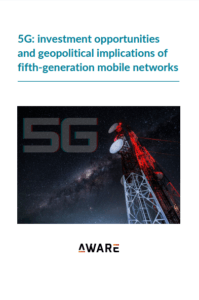Le sfide del trasporto dell'idrogeno rinnovabile ed il ruolo dell'Italia
L’idrogeno rappresenta uno dei potenziali vettori energetici per affrontare le problematiche causate attualmente dalle fonti di energia convenzionali a livello globale, coinvolgendo sia i partecipanti del mercato che il settore pubblico. Attraverso l’equilibrio tra domanda e offerta di idrogeno nel sistema energetico, esso ha il potenziale a lungo termine di ridurre in parte la dipendenza da risorse energetiche provenienti dall’estero, abbassare le emissioni di gas serra e sostituire una gamma di combustibili fossili. Questi aspetti restano validi se l’idrogeno è prodotto da energia elettrica rinnovabile: l’idrogeno verde.
Il trasporto dell’idrogeno è una sfida fondamentale per la sua diffusione su larga scala, dal momento che i costi elevati del trasporto impattano significativamente sui costi complessivi di questo vettore energetico, rappresentando una sfida per la sostenibilità commerciale del settore.
Mentre si attende di capire il ruolo dell’Italia in questo settore, il Paese mostra sicuramente punti di forza dal punto di vista delle infrastrutture e della connettività internazionale, che potrebbero aiutarlo a svolgere il ruolo di transito regionale tra la produzione a basso costo nella regione del Mediterraneo allargato e la grande domanda europea.