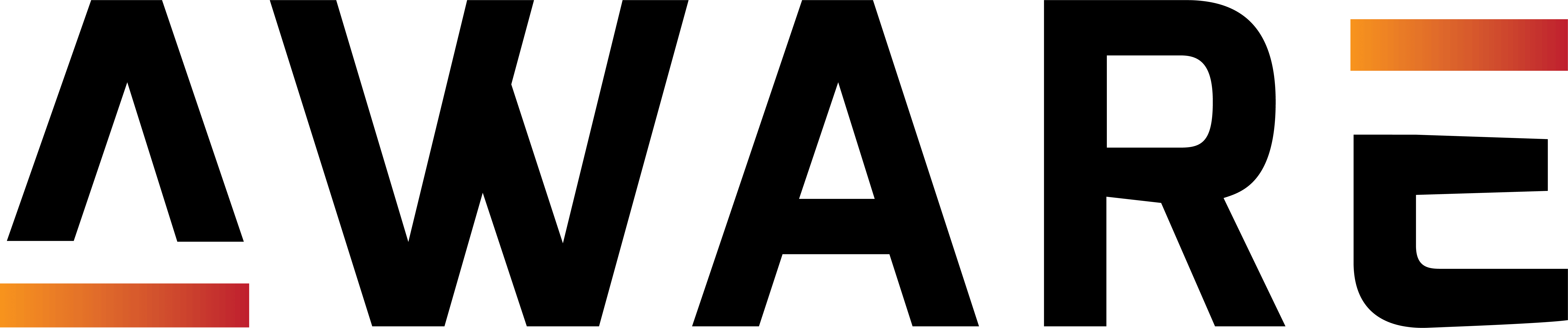L’esito delle elezioni, la disaffezione della società civile
Il 21 Febbraio scorso l’Iran chiamava la popolazione al voto per l’undicesima volta dalla Rivoluzione Islamica guidata dall’Ayatollah Khomeini.
Come da aspettative, la coalizione conservatrice guidata dai cosiddetti Principlists, o hardliners, è uscita dal banco di prova con una vittoria nominale schiacciante, ottenendo una maggioranza parlamentare superiore ai 200 seggi su 290, tra cui la totalità dei 30 relativi alla capitale Teheran, storico baluardo riformista. A farne le spese è stata per l’appunto la frangia dei Riformisti del presidente Rohani, fazione favorevole all’apertura ai negoziati e alle relazioni con l’Occidente, nonché detentrice della maggioranza uscente.
A fronte di tali dati, si rende tuttavia necessaria una serie di considerazioni capace di ridimensionare il successo dei fedeli supporter del leader supremo Khamenei.
In primo luogo, l’elezione è stata caratterizzata dal più basso turnout elettorale nella storia della Repubblica Islamica: le già basse stime offerte dal Ministero dell’Interno iraniano, che prevedevano un’affluenza alle urne vicina al 50%, si sono rivelate eccessivamente ottimistiche, rispetto ad una reale partecipazione attestatasi sul 42.6%. Il disincanto nei confronti del regime è stato particolarmente evidente proprio a Teheran, dove sì, la fazione conservatrice ha ottenuto la totalità dei seggi, ma soltanto a fronte di un palese boicottaggio popolare: infatti, l’affluenza registrata nella capitale non ha superato il 25%.
Le ragioni di tanta disaffezione da parte della società civile sono da riscontrarsi principalmente nell’esclusione ad opera del Consiglio dei Guardiani, organo conservatore addetto al vaglio dell’idoneità dei possibili candidati, di oltre 7000 tra i 16000 potenziali candidati presentati. Come Annalisa Perteghella, Research Fellow di ISPI, sottolinea, tra gli esclusi si contano un gran numero di esponenti moderati e riformisti, nonché 75 deputati uscenti. Posta di fronte alla scelta tra un voto ad opzioni limitate e l’astensione, la maggioranza dei cittadini ha preferito la seconda via, dichiarando così la propria ostilità ad un establishment reo di minare la competizione elettorale a priori. Inoltre, nell’astensionismo ha trovato il suo sfogo anche la protesta contro la violenta repressione delle manifestazioni tenutesi a Teheran negli ultimi mesi, e contro il tentato insabbiamento dell’abbattimento del Boeing ucraino a metà dello scorso gennaio.
L’impatto politico del JCPOA e delle sanzioni internazionali
Una seconda considerazione ha a che vedere con lo sviluppo dei rapporti iraniani con le proprie controparti sullo scacchiere internazionale.
In questo senso, l’amministrazione Trump può senza dubbio essere considerata la miglior amica delle fazioni più rigide ed anti-occidentali dell’establishment iraniano. Infatti, il ritiro dal JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) sul nucleare iraniano e la reimposizione di pesanti sanzioni da parte degli USA hanno indebolito pesantemente la credibilità dei riformisti, attivi promotori della fiducia verso l’Occidente e dei negoziati come via per ottenere una nuova prosperità per il Paese. La fazione conservatrice, da sempre avversa al negoziato ed agli USA, ha potuto invece far leva sull’inaffidabilità e la mala fede statunitensi per promuovere una volta di più posizioni isolazioniste e fondamentaliste.
Il ritiro dall’accordo ed il ritorno ad una strategia di “massima pressione” da parte di Trump sono stati più volte accusati di essere un esempio di bullismo internazionale e malafede, e di costituire un comportamento irrazionale, causa dell’alienamento di un potenziale interlocutore chiave nell’area MENA in favore di Paesi come Cina e Russia. Tuttavia, va sottolineato come la limitazione delle possibilità economiche iraniane faccia sicuramente gli interessi statunitensi: per quanto sul piano della politica interna non sembri esercitare un’influenza efficace, la costante depauperazione di risorse costituisce un potente freno alle ambizioni economiche, militari e regionali dei Persiani.
Se tali restrizioni venissero sollevate, in particolare quelle relative al commercio di risorse naturali, l’Iran potrebbe trasformarsi in una delle economie a crescita più rapida del blocco eurasiatico, con un conseguente aumento esponenziale delle capacità di spesa in campo infrastrutturale, commerciale e di ricerca e sviluppo in tecnologia civile e militare.
Basti pensare alle prestazioni economiche iraniane dopo il periodo 2012-2015, in cui la comunità internazionale si trovò unita nel sanzionare il Paese, con un crollo nel volume delle esportazioni di petrolio di oltre il 50% ed il congelamento di oltre $120bn in assets all’estero. In meno di due anni, la rimozione di un’importante fetta di sanzioni a seguito degli accordi sul JCPOA permise all’Iran di riportare le esportazioni di petrolifere a livelli superiori al 2011, di ottenere accesso a riserve di valuta estera ed ai sistemi finanziari internazionali, di attrarre finanziamenti esteri, e di raggiungere un tasso di crescita del PIL pari al 7%. È in questa luce, dunque, che la prospettiva hawkish dell’amministrazione Trump va interpretata: se già in condizione di forti limitazioni economiche l’Iran è riuscito ad imporsi negli anni come potente competitor e polo d’influenza regionale con ambizioni anti-americane, impedire alla Repubblica Islamica di operare in condizione di prosperità dev’essere priorità fondamentale di USA ed alleati, perlomeno finché accordi più stringenti del JCPOA non saranno rinegoziati.
Tensioni Iran-Usa: escalation sfiorata o leva negoziale?
Infine, un terzo tassello da considerare nell’analisi del risultato elettorale in Iran ha a che vedere con la sicurezza del Paese e le tensioni prettamente militari con gli Stati Uniti ed i suoi alleati.
Sei settimane fa, il 2020 si apriva con l’incubo di un’escalation tra Iran e Stati Uniti. Lo spettacolare omicidio del generale Qasem Soleimani ad opera di un drone statunitense sembrava infatti aver alzato la tensione a livelli insostenibili. Dopo anni passati ad asserire la propria influenza in Medio Oriente per vie indirette, proxy wars, e mutevoli alleanze volte ad isolare l’altro nella regione, tale omicidio mirato sembrava destinato a far precipitare le due forze in causa in un conflitto aperto. Aggiunto ai blocchi navali nello stretto di Hormuz, al focolaio di tensioni rappresentato dal conflitto yemenita, al bombardamento degli impianti della Saudi Aramco, ed alla presa dell’ambasciata USA a Baghdad, l’opinione pubblica internazionale sembrava aver riconosciuto in quest’ultimo atto di sfida la temuta goccia che fa traboccare il vaso.
In merito a ciò, due sono le considerazioni fondamentali da trarre.
In primo luogo, l’omicidio del capo delle forze Al-Quds, nonché figura pubblica tra le più iconiche ed ammirate della Repubblica Islamica, ha prodotto un sentimento di “rally around the flag” ed astio nei confronti delle ingerenze nordamericane nella regione, facendo gioco in favore della linea politica più hardliner in Iran.
In secondo luogo, è opportuno sottolineare come, fin dalle prime battute, nessun addetto ai lavori si sia detto realmente convinto riguardo lo scoppio di una “guerra calda” tra i due attori.
In particolare, vale la pena sottolineare le due chiavi di lettura offerte nel corso della tavola rotonda organizzata da ISPI lo scorso gennaio da due ospiti: la dottoressa Cinzia Bianco (visiting fellow presso ECFR) ed il professor Gianluca Pastori (Associate Professor presso l’università Cattolica di Milano, e collaboratore ISPI). La prima sottolinea come la crisi USA-Iran possa aver facilitato un dialogo tra Repubblica Islamica e monarchie del Golfo: per anni convinti che il contenimento statunitense avrebbe impedito attacchi iraniani, oggi, silenziosamente e tramite intermediari, aprono dialoghi indiretti con l’Iran, in conseguenza di una politica regionale americana meno prevedibile ed allineata di quanto non lo fosse sotto la presidenza Obama.
Dal canto suo, il professor Pastori, interrogato circa il tono del dialogo tra le due potenze, si richiama ad una logica prossima a quella della Guerra Fredda: secondo lui, le due potenze non starebbero confliggendo, bensì cercando posizioni di forza da cui negoziare. In questo senso, l’omicidio di un high value target come Soleimani sarebbe da interpretare come un messaggio di forza statunitense dopo la mancata risposta a una serie di provocazioni iraniane nell’area. Alla stessa stregua, la risposta calcolata persiana, condotta nella forma di un bombardamento con missili tecnologicamente avanzati ma senza casualties americane, sarebbe da interpretarsi come una presa di posizione ferma ma proporzionata di una controparte pronta a porsi sullo stesso livello di sofisticazione.
Un trampolino per i conservatori?
In conclusione, le vicende interne alla vita pubblica iraniana, così come gli sviluppi su scala internazionale, sembrano avere aperto le porte ad un consolidamento sostanziale dell’influenza conservatrice sulle scelte politiche iraniane non solo nel breve, ma anche nel lungo periodo: un nuovo irrigidimento della politica estera persiana, un consolidamento del potere dei Guardiani della Rivoluzione alle leve del governo, la probabile elezione del futuro presidente iraniano, una maggiore influenza sull’elezione del successore di Khamenei in futuro, la fine dell’esperienza moderata.